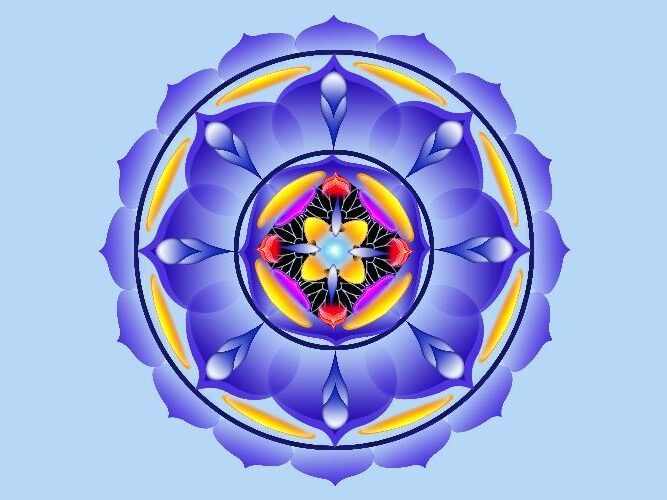di Annalisa Ippolito
Nella sezione orientale del Rijksmuseum di Amsterdam, la collezione di specchi cinesi colpisce per l’elevata raffinatezza dei manufatti, ma ancor più per la densità simbolica delle loro decorazioni. Oggetti raffinati nella fattura e ricchi di simboli, riflettono molto più di ciò che mostrano. Alcuni esemplari presentano motivi che richiamano chiaramente la struttura del mandala: non semplici ornamenti, ma veri diagrammi cosmici che suggeriscono una dimensione contemplativa e cosmologica, un accesso a spazi interiori e trascendenti.
In Cina, l’uso degli specchi risale agli albori della civiltà, già nel secondo millennio a.C., durante l’Età del Bronzo. Questi oggetti, realizzati in una lega ad alto contenuto di stagno, presentavano inizialmente una superficie lucente simile all’argento, che col tempo si è trasformata nei toni del verde e del blu a causa della corrosione. Ma è sul retro che si apre l’universo simbolico: draghi, fenici, figure astratte, elementi cosmici e intersezioni geometriche che rivelano una concezione rituale e magico-alchemica dell’oggetto.
Lo specchio, nella cultura cinese come in molte altre, è soglia e mistero, simbolo e portale. È il punto in cui realtà e illusione si sfiorano, dove l’identità vacilla e si reinventa. Non è un caso che, attraverso epoche e culture, lo specchio sia stato sempre associato al tema dell’ambiguità, del doppio, della metamorfosi.
Nei miti greci, è trappola per l’ego: Narciso perde il contatto con il mondo esterno fissandosi nel proprio riflesso. Nella visione cristiana medievale è invece legato al peccato della vanità, spesso declinato al femminile, come nel pannello della Superbia nei Sette peccati capitali di Hieronymus Bosch: lo specchio diventa qui strumento di perdizione, ma anche di rivelazione. In epoca moderna, si fa simbolo dell’inconscio e delle sue ombre: nel Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde la funzione metaforica dello specchio simbolo dell’anima corrotta è manifestata dal dipinto, dal ritratto del protagonista. Il dipinto riflette l’ombra dell’anima è l’alter ego mostruoso e rimosso. Lo specchio/dipinto racconta ciò che non si vuole vedere.
Con l’avvento della psicanalisi, l’immagine riflessa acquisisce una nuova dimensione: quella del teatro interiore. A partire da Freud, la psiche viene rappresentata come un sistema stratificato – Es, Io, Super-Io – e lo specchio diventa figura del conflitto tra desiderio, coscienza e maschera sociale. Con Lacan, lo specchio diventa figura fondativa dell’identità: nello stadio dello specchio, il soggetto si riconosce nell’immagine riflessa, costruendo un io che è già alienato, frammentato, illusorio. Il riflesso diventa così scena psichica, tra desiderio, immaginario e maschera. L’autoritratto – basti pensare a Van Gogh – assume i contorni di un’indagine spietata sul sé, tra bisogno di affermarsi e vertigine dell’autoannientamento.
Nella cultura buddhista giapponese, lo specchio assume un significato radicalmente diverso: è emblema di purezza, saggezza, della verità che si riflette senza essere trattenuta. In questo contesto, riflettere è metafora della capacità di rimanere incontaminati, come la mente illuminata che osserva senza aggrapparsi al possesso. In questa chiave, lo specchio non deforma, non giudica: mostra, e basta. Resta immobile mentre tutto passa. Ed è proprio in questa trasparente impersonalità che diventa via di conoscenza spirituale. Come il mandala può diventare via di accesso a una realtà più profonda. È un dispositivo alchemico: superficie che riflette ma anche spazio iniziatico, in cui gli opposti si incontrano e si trasmutano. Dal buio della caverna platonica si intravede, riflessa, una possibile luce.
L’iconografia specchiante si intreccia così con la filosofia, la psiche e la spiritualità. Lo specchio come il mandala permette l’ampliamento dello spazio, il gioco tra visibile e invisibile, tra realtà e rappresentazione. Permette di vedere ciò che non è direttamente visibile, come un occhio parallelo, nascosto ma rivelatore. La sua applicazione nelle arti visive ha consentito di esplorare il confine tra occhio e sguardo, tra percezione e significato, tra apparenza e verità. È, al tempo stesso, superficie e profondità.
Come il mandala, anche lo specchio può essere letto come una figura di mediazione: tra mondo interno e mondo esterno, tra io e altro, tra caos e forma. È il luogo della coincidenza degli opposti, dove può avvenire , se ci si lascia attraversare, una trasformazione. È dispositivo alchemico, soglia psichica, luogo dell’immaginazione attiva.
In questo senso lo specchio, proprio come il mandala non è soltanto un oggetto d’uso, ma una soglia universale. Trovare uno specchio in un mandala individuale, o riconoscerne le forme in uno antico, può significare vedere riflessa la propria interiorità, osservata non come qualcosa da possedere, ma da attraversare.
Davanti a questi antichi specchi del Rijksmuseum, non mi limito a guardare: sono guardata. E mi viene chiesto di rispondere alla più antica delle domande: chi sono, davvero, oltre il riflesso?
Foto di copertina: Collage di specchi, Rijksmuseum, Amsterdam. Foto di Annalisa Ippolito.